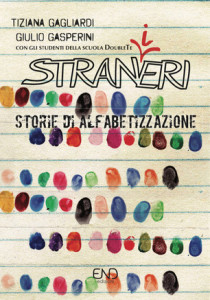LC: Caro Giulio, piacere di ritrovarti sulla nostra pagina. In precedenza abbiamo accolto tue poesie, reportages sociali e ambientali, brevi saggi, soprattutto legati a Lampedusa…spiegaci un po’, il legame con l’isola continua? Ha dato vita a nuove riflessioni e collaborazioni?
GG: Grazie a voi dello spazio che ogni volta mi concedete sulle pagine virtuali di questa meravigliosa rivista. Il rapporto con Lampedusa continua e si fa forte ogni volta di più: oramai è una delle mie case, io che non mi sono mai veramente sentito appartenente a nessun luogo in particolare. Ogni volta, ritornare a Lampedusa è scoprire qualcosa di nuovo, è un’esperienza di cura – personale, innanzitutto – che fa maturare considerazioni e pensieri; è un luogo che amplifica ogni emozione e che ti lascia, fortunatamente, con più dubbi di quelli che vorresti ma che spingono a cercare, ad andare oltre. Negli ultimi anni, la frequentazione di Lampedusa è legata alla vita della straordinaria Biblioteca Ibby, dove ogni anno viene organizzato un campo di lavoro che mi ha permesso di conoscere i ragazzi e le ragazze di Lampedusa, di parlare e ragionare con loro di libri, letture, sogni e narrazioni. Ed è stata un’esperienza che mi ha fatto conoscere e messo in contatto con tantissime persone eccezionali che lavorano in Italia e nel mondo in funzione di una pacificazione sociale e comunitaria che è quanto mai necessaria nell’Italia nervosa e feroce di oggi.
LC: Ci siamo conosciuti di persona frequentando lo stesso Master Itals dell’Università di Venezia, rivolto all’insegnamento dell’italiano a stranieri. Com’è evoluta da quel momento la tua vita di docente d’italiano a migranti in Italia? Quali esperienze ti hanno portanto a stringere un rapporto meno teorico e più concreto e quotidiano con la diversità?
GG: L’esperienza dell’insegnamento dell’italiano a stranieri, in particolare a richiedenti asilo, e, ancora più in particolare, a persone analfabete e scarsamente alfabetizzate, mi ha messo a dura prova: è uno degli insegnamenti più difficili e complessi io abbia mai affrontato, perché ci mette di fronte a una situazione per noi sconosciuta, quella appunto dell’analfabetismo, ma che riguarda persone adulte, con un passato alle spalle, dei talenti, dei sogni, dei rapporti familiari e sociali che lo trasformano in un apprendente complesso e difficile da stimolare. Con gli studenti analfabeti non ci sono manuali che possano essere esaustivi: si procede con fatica, attraverso tentativi ed esperimenti, spesso sentendosi frustrati dei risultati che appaiono troppo deludenti. Si fa una fatica enorme perché bisogna preparare tutto, adattarlo, stravolgerlo, seguire ogni apprendente, per quanto possibile. Però c’è un momento che riscatta da ogni fatica e frustrazione: quello in cui lo studente si meraviglia di aver iniziato a leggere e a scrivere. Il loro stupore, la loro nuova consapevolezza sui propri mezzi è il momento per cui vale la pena affrontare questo faticoso lavoro.
LC: Hai da poco pubblicato Stran(i)eri. Storie di alfabetizzazione (2019, END, Gignod), assieme a Tiziana Gagliardi e agli studenti della scuola DoubleTe, un libro fortemente plurale, da consigliare a chi fa il tuo stesso mestiere. Raccontaci com’è nato e quali sono gli obiettivi della sua diffusione.
GG: Il libro fa parte del progetto Stran(i)eri e ha il suo “gemello” in un altro libro, “Storie a fumetti di migrazione”, che raccoglie i lavori a fumetti realizzati dagli ospiti del CAS di Nus durante un laboratorio condotto dalla fumettista Erika Centomo. Con la mia collega Tiziana abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno far uscire gli studenti e la scuola DoubleTe all’esterno delle sue aule e delle sue mura, per far conoscere a tutti il meraviglioso percorso di apprendimento che lì dentro è avvenuto. Abbiamo pensato, pertanto, di realizzare un prodotto che fosse testimonianza esperienziale, piuttosto che manuale didattico, per far compiere ai lettori un viaggio di immedesimazione in persone che si impegnano in un percorso faticoso e pieno di ostacoli, che noi non possiamo neanche immaginarci. I due volumi hanno tanti obiettivi, principalmente quello di raccontare due esperienze positive (e forse uniche) nell’ambito dell’accoglienza straordinaria di richiedenti asilo in Italia. Della Valle d’Aosta si parla sempre poco e, quando accade, come in queste settimane, è sempre per qualche aspetto estremamente mortificante: è una regione, però, che sa dare esempi anche di eccellenti pratiche e straordinario impegno, come in questo caso. Sono due libri che ci fanno incontrare i migranti da angolazioni diverse, in un ruolo voluto di partità e non, come sempre, in un rapporto squilibrato di potere (nostro). La scuola, a causa dei tagli effettuati dall’allora Ministro Salvini sui bandi dell’accoglienza, è stata chiusa: “Stran(i)eri. Storie di alfabetizzazione” è il regalo che gli studenti fanno a tutte e tutti.
LC: La metafora, molto azzeccata, dell’albero e delle sue parti permea ogni capitolo del libro, così da proporre una nuova visione della pratica dell’insegnamento dell’italiano che metta al centro l’individuo, la sua storia, i suoi sogni come attore dell’apprendimento e della nuova vita…ci potresti illustrare meglio la metafora e come, in realtà, sia il riflesso delle pratiche educative sperimentate con la DoubleTe?
GG: La scuola DoubleTe, anche grazie alle nostre preziose maestre e formatrici dell’Associazione Asinitas di Roma, ha fatto proprio l’insegnamento di Paulo Freire per quanto riguarda il “tema generatore di discorso”; un discorso che deve essere quanto più possibile includente e condiviso, per il quale tutti abbiano qualcosa da dire. Come direbbe Ernesto De Martino, siamo partiti da un’immagine “elementarmente umana”, patrimonio comune, al di là dell’origine e della cultura. A scuola, abbiamo sempre scelto di “fare pensiero” non utilizzando manuali già pronti – non ce ne sono di adatti alla figura del richiedente asilo nel panorama editoriale italiano – ma attraverso la preparazione di materiali creati appositamente, utilizzando anche testi letterari (dal Cantico dei Cantici a poesie di Giuseppe Ungaretti, Walter de la Mare, Wislawa Szymborska e altri) e soprattutti i testi degli alunni. L’immagine dell’albero, oltre a essere fonte di discorsi comuni, si è prestata bene alla sua lettura metaforica: le radici, il tronco, i rami, la chioma, il bosco possono diventare facilmente rappresentazioni evocative delle fasi dell’esistenza personale, del passato del presente e del futuro, attorno ai quali procede ogni narrazione umana: l’uomo si racconta (a sé e agli altri) attraverso narrazioni e la scuola, in questo, non è diversa.
LC: Il vostro libro è anche un bel lavoro di risignificazione della cicatrice lasciata dalla migrazione violenta, via mare o via terra. Ad esempio, il capitolo dedicato alle impronte mi sembra peculiare, ce ne vuoi parlare?
GG: Il lavoro sulle impronte digitale nacque proprio in relazione all’arrivo ad Aosta di un gruppo di richiedenti asilo appena “sbarcati”. Quando i migranti giungono nella loro sede di destinazione, per l’accoglienza, vengono subito fotosegnalati in Questura e viene formalizzata la loro richiesta d’asilo. Tutti loro sono consapevoli che farsi fotosegnalare, e quindi depositare le impronte digitali, significa che il loro percorso è, di fatto, bloccato in Italia: per il Regolamento di Dublino non possono andare in altri stati ma devono terminare l’iter qua. Il rapporto con i loro corpi, quindi, diventa estremamente conflittuale, perché sanno che le loro mani, che di solito si usano per lavorare, accarezzare, toccare, prendere e per tanti altri mille usi quotidiani, sono la “causa”, in un certo senso, dell’attuale momento di esistenza. Abbiamo voluto provare a attribuire ai polpastrelli, alle impronte digitali, anche un valore positivo, cercando di riconsegnare al corpo, e alla sua memoria, un significato costruttivo: abbiamo così pensato di iniziare a lavorare sul lessico relativo alla mano e poi abbiamo dipinto il nostro autoritratto utilizzando le dita. Uno degli aspetti più difficili per un migrante è che spesso, nel corso della procedura di richiesta asilo, rischia di essere appiattito nella sola dimensione di “corpo dolorante”, è quindi centrale riprendere confidenza anche con le dimensioni più positive e costruttive della propria presenza fisica, del proprio corpo, appunto. È il motivo, ad esempio, per il quale, a scuola, si insegnava e si imparava anche occupando lo spazio, muovendoci, correndo, cantando. Il corpo ha memoria e il corpo apprende e, in ultimo ma non meno importante, il corpo è politico.
 LC: “Lettera alle italiane e agli italiani ou au gouvernement, c’est la même chose” chiude il libro e condensa una visione duale dei migranti, per cui l’Italia è la loro salvezza, ma anche terra di discriminazione. Cos’è emerso dal dialogo con i tuoi studenti migranti, fuori e dentro l’aula?
LC: “Lettera alle italiane e agli italiani ou au gouvernement, c’est la même chose” chiude il libro e condensa una visione duale dei migranti, per cui l’Italia è la loro salvezza, ma anche terra di discriminazione. Cos’è emerso dal dialogo con i tuoi studenti migranti, fuori e dentro l’aula?
GG: L’esperimento di quella lettera, realizzata con la tecnica della scrittura collettiva secondo l’insegnamento di don Milani e della Scuola di Barbiana (affinché tutti possano contribuire, con quello che hanno, alla realizzazione e al successo di un testo scritto), è arrivato in un momento particolare della scuola, durante il quale la politica berciata e molesta era pesantemente entrata in classe, perché tutti gli studenti sentivano il clima aggravarsi attorno a loro e sapevano che i tempi stavano cambiando, decisamente in peggio. La lettera corrisponde al tentativo, portato avanti nella nostra scuola, di far riappropriare gli studenti di quel “diritto alla parola” di cui sono privati nel momento in cui assumono la realtà giuridica di richiedenti asilo: durante questo processo, infatti, in nessun momento viene chiesto loro di esprimersi, neanche quando, di fronte alla Commissione territoriale, devono raccontare la propria storia per aver riconosciuta una protezione: non è un’intervista neutra ma un atto di potere da parte dello Stato. Abbiamo voluto, per una volta, lasciar liberi gli studenti di dire quello che volevano ai cittadini e alle cittadine italiane, anche nelle loro lingue ponte, affinché anche loro potessero tornare a contare per sé stessi e per le proprie idee, indipendentemente da tutto il resto. La coralità aiuta l’individuo, lo fa risuonare e ne diffonde con più fermezza e potenza il pensiero.
LC: Il vostro lavoro si completa con l’altro libro edito da END: Stran(i)eri. Storie a fumetti di migrazione. Quant’è importante il lavoro visuale, acconto a quello con la parola? Quali canali può attivare?
GG: Il laboratorio di fumetto, condotto dalla fumettista Erika Centomo, è stato altrettanto significativo nel percorso dei partecipanti, perché ha dato loro modo di confrontarsi con un linguaggio inusuale e diverso, ma attraverso il quale hanno potuto affrontare argomenti e fornire delle narrazioni che con la sola parola sarebbero state impensabili e impossibili. L’avvicinamento al fumetto è stata un’esperienza estremamente insolita per loro, ma ha permesso di riflettere anche sull’importanza della parola, sul suo utilizzo, sul modo in cui viene percepita e raccolta dagli altri. Non è stato un esperimento semplice, perché molti richiedenti asilo non avevano proprio l’abitudine (anche culturale) di utilizzare il disegno, che invece noi diamo troppo per scontato. Inoltre, il linguaggio del fumetto è estremamente codificato, così da essere intellegibile facilmente da parte di lettori che appartengono alla stessa cultura dell’immagine. Dopo le prime difficoltò, però, l’avventura è stata estremamente interessante e profonda, perché ha contribuito a mettere sullo stesso piano ospiti e operatori, tutti attivi partecipanti del laboratorio, ognuno con la propria voglia di narrare e le proprie storie da regalare. Il volume è accompagnato, poi, da alcune storie di fumettisti di fama internazionale, che hanno voluto partecipare attivamente a questo progetto: Arianna Farricella, Giuseppe Palumbo, Luca Enoch.
LC: Venendo un po’ al contesto politico italiano in cui si iscrive il tuo lavoro…ti sembra che le Sardine avranno un peso duraturo nel costruire un’Italia oltre il salvinismo? Sarà risucchiata da logiche di partito? Insomma, che potenzialità e limiti avverti?
GG: Sulle sardine si sta scrivendo di tutto e di più. A me, personalmente, stanno simpatiche: mi piace il loro principio di contestare un linguaggio feroce e brutale, che ha ricevuto una legittimazione istituzionale indecorosa per un paese civile. Mi piace il loro essere eterogeneo, questa composizione varia di giovani, adulti, persone ancora più adulte, bambine; mi piace il loro cantare “Bella ciao” come segno di unità – perché la Carta costituzionale, bellissima, che regola la vita civile italiana nasce da quell’esperienza di resistenza e di contrasto al tiranno e alla tirannia; trovo bello che siano raduni educati e pacifici; trovo emozionante che siano tornate a impadronirsi di spazi cittadini pubblici. Abbiamo assistito, in Italia, a numerose esperienze di associazionismo spontaneo che, a detta di alcuni, spesso si sono concluse con un nulla di fatto e si sono disperse senza lasciare apparente traccia. Io trovo, invece, che anche la loro presenza nelle piazze sia qualcosa di non scontato e di utile: dobbiamo tornare a immaginare il corpo come un elemento politico, soprattutto in un’epoca che ci nasconde dietro le tastiere e gli schermi e ci fa perdere un po’ la dimensione più fisica dell’agire politico. E, soprattutto, dobbiamo tornare a dare valore alla società civile, alle sue dinamiche, alla sua forza d’impatto e alla sua capacità di influire sulla politica del potere, senza confondere i piani, come direbbe Hannah Arendt.
LC: Più in generale, dove collochi le origini del razzismo italiano? Cosa credi che riuscirà a smontare la retorica razzista instauratasi nella società italiana? Quali alternative vedi?
GG: La questione temo che sia piuttosto complicata. Il razzismo italiano, secondo me, nasce non tanto da un’idea di effettiva superiorità razziale o culturale, quanto invece dal terrore insito nella cittadinanza italiana, che è quello del disagio, della sofferenza, della difficoltà. Il migrante, che più di tutti viene strumentalizzato in quest’ottica razzista, è uno specchio: rimanda alla persona che lo guarda un’immagine di sé stessa che non piace. Il migrante riflette le nostre meschinità, le nostre bassezze, i nostri più indicibili segreti, le nostre imbarazzanti perversioni, che soffochiamo prepotentemente da tempo. Il migrante ci fa sentire disarmati, completamente indifesi alla vulnerabilità dell’esistere e dell’esistenza. Il migrante ci spoglia, ci lascia nudi all’assalto del caso, al dramma dell’inesorabilità della sorte. Il migrante ci fa ricordare, con orrore, che quel destino potrebbe colpire tutti, anche noi, e che ben presto potremmo trovarci a dover combattere di nuovo per la pura sopravvivenza, come già accaduto. Il migrante ci paralizza nel terrore della sofferenza, del dolore cupo e feroce, ci ricorda che il corpo può soffrire, straziato e schiantato da sadismi ed efferatezze spietate. Il migrante è il nostro specchio perché siamo terrorizzati, oramai, della povertà, della mancanza di possesso, del terrore di affrontare il potere (come lui, il migrante, è invece condannato a fare costantemente). Il migrante è il nostro specchio perché negli occhi c’è tangibile il senso profondo di cosa significa stare aderente e aggrappato alla vita, nel senso più compiuto e furioso, un richiamo prepotente che non si può, e non si deve, fermare davanti a nessun ostacolo. Abbiamo seppellito il nostro disagio, il terrore della nostra fragilità sotto tonnellate di benessere, negli iPhone, nelle macchine sempre più perfette, nell’illusione di possedere tutto il mondo possedendo un potente passaporto, fingendo di dimenticarci la nostra fugacità sdraiati sulla sabbia o ballanti in una discoteca. Ci affacciamo alle rive del Mediterraneo occupandoci solo della nostra tintarella e proviamo un’irritazione indecente nei confronti di chi ci ricorda che quel mare è un’enorme fossa comune. Il migrante ci ricorda che il nostro benessere significa il malessere di altri, in un perverso sistema di vasi comunicanti che ci ha narcotizzato e, persino, autoassolti; perché, se qualcheduno deve stare necessariamente male, meglio lui di me. Sicché il migrante ci spaventa solo perché ci ricorda che siamo meschini, che abbiamo soffocato la nostra capacità di com-patire e di indignarci perché era più comodo e facile anestetizzarsi e far finta che, alla fine, tutti sono uguali e sono tutti la stessa merda. Per questo, respingiamo il migrante: non lo vogliamo proprio vedere, muoia pure lontano, ché se non lo si vede vuol dire che non esiste. Quello che non sappiamo (e che non intendiamo volontariamente sapere) non ha diritto di parola né, tantomeno, d’esistenza. Lo classifichiamo “migrante” per non pensarlo essere umano, per non tenere conto delle narrazioni di vita, di presenza, dei talenti, dei meriti, delle competenze, delle abilità, delle vocazioni, delle abilità, dei prodigi. Ma l’esistente (quello sano, quello che sa di non possedere nulla e di aver tutto da guadagnare) sobbolle e fermenta e avrà la sana forza tellurica di un’eruzione. Incontenibile.
LC: Grazie per il tuo tempo, Giulio, e aver condiviso la tua esperienza e la tua opinione.
 GIULIO GASPERINI Laureatosi nel 2010 in Italianistica, oggi è redattore del settimanale on-line di libri e editoria Chronicalibri.it. Autore di poesie, ha pubblicato quattro sillogi poetiche – Dedicate, Schegge di mandala (2006), Patologia (2010) e Migrando (End Edizioni, 2014) – e ha curato la pubblicazione di altri libri, tra cui quello dell’attivista curda Ezel Alcu (Senza chiedere il permesso. Il mondobastardo, End Edizioni, 2018) e il libro della scuola di italiano DoubleTe per richiedenti asilo e rifugiati dove ha lavorato dal 2017 al 2019 (Stran(i)eri. Storie di alfabetizzazione, End Edizioni 2019). Ha da sempre la passione dei viaggi, che lo ha portato in varie zone del globo, dalla Bolivia al Kenya, ma è profondamente affezionato alla sua terra natia e al suo paesino, Caldana, nella Maremma toscana. Attualmente vive ad Aosta, dove lavora come operatore sociale (nei settori immigrazione e povertà) e insegna italiano a stranieri. Tiene corsi di officina poetica. Dal novembre 2019 è Presidene dell’Arcigay Valle d’Aosta.
GIULIO GASPERINI Laureatosi nel 2010 in Italianistica, oggi è redattore del settimanale on-line di libri e editoria Chronicalibri.it. Autore di poesie, ha pubblicato quattro sillogi poetiche – Dedicate, Schegge di mandala (2006), Patologia (2010) e Migrando (End Edizioni, 2014) – e ha curato la pubblicazione di altri libri, tra cui quello dell’attivista curda Ezel Alcu (Senza chiedere il permesso. Il mondobastardo, End Edizioni, 2018) e il libro della scuola di italiano DoubleTe per richiedenti asilo e rifugiati dove ha lavorato dal 2017 al 2019 (Stran(i)eri. Storie di alfabetizzazione, End Edizioni 2019). Ha da sempre la passione dei viaggi, che lo ha portato in varie zone del globo, dalla Bolivia al Kenya, ma è profondamente affezionato alla sua terra natia e al suo paesino, Caldana, nella Maremma toscana. Attualmente vive ad Aosta, dove lavora come operatore sociale (nei settori immigrazione e povertà) e insegna italiano a stranieri. Tiene corsi di officina poetica. Dal novembre 2019 è Presidene dell’Arcigay Valle d’Aosta.
Immagine in evidenza: Opera grafica di Irene De Matteis.