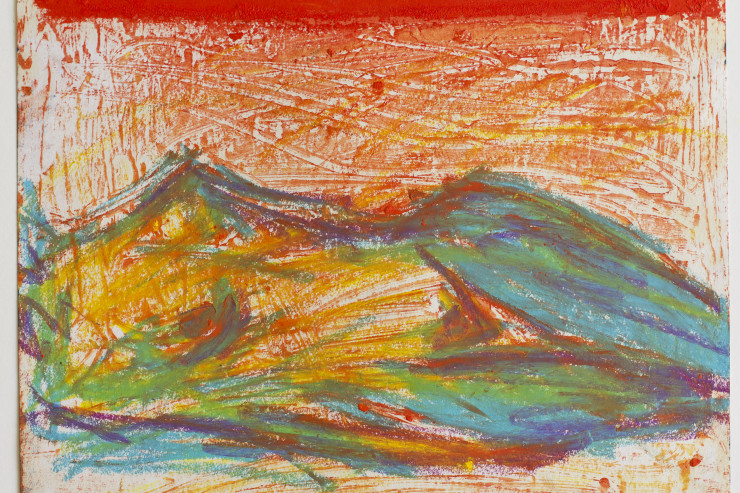Nell’ambito dell’Internazionale a Ferrara 2017, il 30 settembre, nella sezione “Siria”, sono stati ospiti lo scrittore siriano Khaled Khalifa, autore di “Elogio all’odio” (Bompiani, 2011) e il poeta siriano Faraj Bayrakdar, autore del “Il luogo stretto” (nottetempo, 2016), intervistati dall’arabista Elisabetta Bartuli. “Armati di parole, scrivere per resistere alle dittature e sopravvivere alla guerra” era questa il titolo del loro profondo intervento che ha toccato tematiche quali la “Letteratura di prigionia”, la testimonianza di Bayrakdar dei quattordici anni vissuti nelle peggiori carceri siriane sotto le torture del regime di Assad padre, l’importanza della figura della donna per entrambi gli scrittori, i ricordi di Khalifa legati ad Aleppo e al massacro del regime perpetrato negli anni Ottanta, tematica anche del suo famoso “Elogio all’odio” (titolo originale: Madīḥ āl karāhyat). In particolare, all’affermazione dell’arabista secondo cui Khalifa scrive della sua Aleppo per “dovere di memoria”, lo scrittore risponde: “è molto difficoltoso per me questo inizio, perché parlare della città che mi è più cara è molto difficile. Aleppo per me non è solo una città in cui ho vissuto ma è una città con cui ho un rapporto quasi mistico, penso alla mia infanzia, al mio lungo percorso che ho fatto lì e quindi mi è difficile parlare di ciò che oggi accade ad Aleppo. (…) Anche se scrivo di un’altra città, involontariamente torno a parlare di Aleppo, è il mio cuore che mi porta lì. Io dico che non ha senso scrivere senza emozioni e senza cuore … per me Aleppo è una città che non è finita e che non finirà mai. Così come Nagib Mahfuz ha scritto del suo Cairo, così io continuerò a parlare della mia Aleppo. (…) A volte divento fanatico della mia città, alcuni mi scrivono che sto esagerando ma io rispondo che oggi Aleppo è debole, è distrutta e che ha bisogno che qualcuno parli di essa, anche esagerando nell’amore.” E proprio a proposito dell’amore, lo scrittore afferma che è stato quello per la scrittura a salvarlo, a guarirlo da una forte crisi di malinconia che ha avuto nei tredici anni passati. Dichiara che quando ha finito di scrivere “Elogio all’odio” si è sentito guarito dalle sue ferite, così come i tanti siriani che hanno letto il suo romanzo e che, fermandolo per strada, lo ringraziano perché sentono che le sue parole hanno in qualche modo alleviato anche il loro dolore.
Proseguendo l’intervista, Bartuli chiede l’importanza delle donne nella loro opera, donne che risultano forti, che dominano nelle loro composizioni. Khalifa, in cui nell’”Elogio all’odio” affida la narrazione ad una ragazza, si vanta della sua capacità di essere amico delle donne e quindi di comprenderle fino al punto in trasformarsi in una di loro: “Nell’Elogio all’odio la voce narrante è una donna e questo è stato per me un modo per elogiare le donne e quando scrivevo io stesso mi trasformavo in una donna”. Ancora, ricordando l’importanza che le donne della sua famiglia hanno avuto nella sua vita, dice: “La vita non può essere costruita senza donna, le donne riescono a costruire la vita dalle cose più piccole (…). Io ho un debito verso di esse: guardo le donne con cui ho vissuto e dico se non fosse stato per loro, non sarei stato nessuno. Guardo agli uomini e penso che siamo sempre noi quelli che distruggiamo, mentre le donne sono quelle che ci raccolgono (…). Ho tante amiche donne che mi parlano con tanta sincerità e chi riesce ad essere amico delle donne sta in buone mani, non dovete preoccuparvi per lui.”
Quanto al poeta Faraj Bayrakdar, il suo intervento verte principalmente sull’esperienza del carcere, motivo per cui la sua poetica rientra nella “letteratura di prigionia”. Come lui stesso racconta, venne arrestato nel 1987 dal regime di Hafez al Assad con l’accusa di essere un comunista. Assieme a lui, il regime arresta altri due fratelli, uno con l’accusa (infondata) di appartenere alla Fratellanza musulmana, motivo per cui venne condannato a nove anni di carcere. Il poeta racconta di quella che Bartuli chiama “ossessione buona del carcere”, ovvero priva di rancore, dove Faraj trascorre quattordici anni della sua vita. Afferma che il tempo sia volato e che alla fine, quei quattordici anni, sembra che ora si siano ridotti in ore, le ore che hanno scandito le fasi della sua esistenza “Quattordici ore è la mia infanzia, quattordici ore è la mia giovinezza, quattordici ore è la mia prigione ed altre quattordici ore sono sparse qua e là”. In quel “sparse qua e là” è impossibile non leggervi il suo esilio dalla Siria, la sensazione di vagabondare nell’attesa del ritorno. Bayrakdar riesce coraggiosamente a risvegliare i ricordi più dolorosi, come quella volta, racconta, che grazie ad un foglietto che gli passò il secondino dove erano riportati tutti i nomi dei detenuti in quel carcere e la loro collocazione esatta, constatò che il fratello minore fosse nello stesso edificio. Ricevuto il permesso di incontrarlo, dentro di sé s’impose di non piangere al fine di dargli l’esempio di dover essere forte ma sentendo intorno a lui il pianto dei suoi compagni detenuti che piangevano di gioia per il poeta, anche lui, alla fine, non riuscì a trattenere le lacrime, “questo è un attimo più duro di una sessione di tortura” conclude. Riguardo al dolore, spiega che, tentando di trovare le parole adatte per raccontarlo, constatò alla fine che non esistono parole né lingue in grado di esprimere quel tipo di dolore. “Uno dei libri che scrissi in prigione non era una raccolta di poesia, era una specie di diario. Raccontava delle tappe più importanti della mia prigionia. Ho intitolato questo libro “I tradimenti della lingua e del silenzio” perché ho scoperto che mentre scrivevo nessuna lingua può davvero esprimere questa esperienza. Oggi, mentre scrivo, continuo a soffrire perché la mia testa rievoca quegli anni di dolore ma non ho scelto perché ho promesso agli altri prigionieri che sarei stato io la memoria. Io, come scrittore, non posso non parlare, il silenzio è un tradimento.
Poi, alla stessa domanda riguardo all’importanza della donna che Bartuli rivolge anche a Khalifa, il poeta risponde: “Quando ero giovane mi rapportavo alle donne come si rapportavano i poeti. Un amore che rispecchia la poesia vergine, platonica, in cui la donna viene innalzata. Nel carcere, sotto tortura, mentre tutto il mondo attorno a me gridava dal dolore, veniva a me il desiderio di una donna che potesse curarci le ferite, come una sorella. Io arrivo da un ambiente in cui i ragazzi sono orgogliosi per le loro sorelle e non per i loro fratelli. In carcere, dove ci sono solo uomini, c’è urgenza di una figura femminile, allora ognuno s’immagina la propria donna ideale ma questa donna include in sé tante donne perché magari gli occhi sono di una, il corpo di un’altra e il prigioniero pensa che quando uscirà dal carcere incontrerà questa donna ideale. Ecco, questo è un pensiero che dà sollievo, che protegge le emozioni, la propria umanità, evita di diventare delle pietre, di essere odiosi. Ci sono altri aspetti riguardo alla donna … ad esempio, in prigione la donna acquisisce una dimensione sacra e si guarda a questa immagine in modo astratto perché sotto tortura non si ha desiderio fisico ma la donna, in quella situazione, diventa lei il simbolo della libertà.”
I due scrittori concludono l’intervista sottolineando che la Siria non vedrà la propria libertà se non con la caduta del dittatore Bashar al Assad, Faraykdar sostiene fieramente “Sarebbe stato sufficiente che una sola famiglia europea avesse accolto una siriana, ovvero quella di Bashar al Assad, che andandosene avrebbe risparmiato tanti morti e tanta sofferenza” e quando un giovane rifugiato siriano in Italia gli chiede le sensazioni di vivere oggi sotto il regime, dopo sei anni in cui Bashar figlio ha massacrato il suo popolo e martoriato la propria terra, Khaled Khalifa risponde: “Io stavo a casa mia, non stavo sotto il regime, quando uno vive in Siria uno sta a casa sua e non sotto il regime perché è il regime ad essere l’intruso, a non fare parte di questo Paese, è il regime che deve lasciare la Siria, non io, io vivo a casa mia.”
Report inedito, per gentile concessione di Elena Calogiuri.
Elena Calogiuri è laureanda in lingua araba all’Università di Bologna, con una tesi sulla letteratura moderna siriana e palestinese, in cui ha tradotto degli inediti di Darwish, al Maghout e Tuqan. Dal 2013 ha iniziato l’attività di volontariato a favore del popolo siriano, recandosi più volte al confine turco – siriano dove, tra le diverse attività, ha svolto dei workshop di cucito in lingua araba in una scuola di bambini siriani. Nel 2016 è stata un mese in Grecia, al campo di prima registrazione di Moria e ad Idomeni, ricoprendo la funzione di interprete dall’arabo all’inglese per diverse associazioni umanitarie. Dal 2014 ha pubblicato diversi articoli sulla situazione geopolitica in Siria, tenendo inoltre una sua rubrica di attualità dal titolo “La Siria che muore ” per una testata giornalistica torinese.
Foto dell’autrice a cura di Elena Calogiuri,
Immagine in evidenza: dipinto di Barbara Gabriella Renzi Iule.